|
 Umorismo
e combattività
Umorismo
e combattività
Leandro Konder
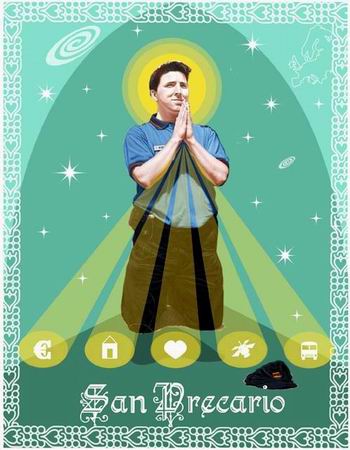
La parola "umore" è nata nel campo della medicina. Si
pensava, nel Medioevo, che i caratteri degli esseri umani fossero determinati
dagli "umori". Questa credenza proveniva dall'Antichità: nel
2° secolo d.C., Galiano riteneva che gli umori fossero quattro: il sangue,
la flemma, la bile gialla e la bile nera.
La bile nera, mali conia,
in eccesso generava malinconia. La flemma in eccesso generava indifferenza. La
bile gialla era legata alla collera, agli eccessi di ira. Il sangue, pressando
troppo, causava emorragie (per evitare questo, i medici usavano le sanguisughe).
Questo
uso del termine "umore" è presente in diversi autori, cristiani
e arabi, medievali e rinascimentali. Lo troviamo, per esempio, nelle commedie
di Ben Johnson, in Inghilterra. Gli "umori" venivano menzionati dagli
autori che cercavano di spiegare il motivo per cui determinati personaggi, agivano
come agivano. Gli autori di testi comici erano portati a credere che la tendenza
al ridicolo fosse una conseguenza dell'eccesso di un "umore" peculiare,
che però non era nessuno dei quattro sopra citati. Questa linea di pensiero
portava gli osservatori a focalizzare la loro attenzione sul soggetto, più
che sull'oggetto, sugli autori, più che sulle opere.
Col passare del
tempo, intanto, la teoria si indebolì. Man mano che la adottavano, le persone
si rendevano conto che le osservazioni che facevano non erano del tutto convincenti.
Se l'umore fosse derivato da "umore" del nostro organismo, chi fosse
stato più provvisto di questo "umore" avrebbe avuto più
fecondità "umoristica". Tuttavia, possiamo constatare che esistono
soggetti sempre in malumore, ma comunque buffissimi. Esistono soggetti sempre
di buon umore ma senza simpatia.
Quindi, il problema non è dei soggetti:
si riscontra nella realtà oggettiva delle opere. Appartiene al lato estetico
del comico. Nelle commedie, nelle parodie, nelle satire, c'erano senza dubbio
scene, situazioni, personaggi, che facevano ridere. Ma gli scrittori e i lettori
si chiedevano: da dove venivano queste risate? Cos'è che faceva tanto ridere?
In
generale, è stato necessario iniziare da una battaglia preliminare, attorno
al riconoscimento della commedia come genere letterario "rispettabile",
degno di ammirazione. Già nella Grecia antica, c'era molta resistenza a
questa valorizzazione del comico, come si vede nelle invettive fatte contro gli
scritti di Aristofane.
Aristotele, il filosofo, ha incluso nella sua Arte poetica
una parte dedicata alla commedia, che, nel frattempo, si è persa. (L'italiano
Umberto Eco, nel suo romanzo "Il nome della rosa", ha creato un personaggio
di finzione - Jorge de Burgos, sacerdote cieco, ultraconservatore - che ha distrutto
l'ultima copia che ancora esisteva della Commedia di Aristotele, argomentando
quello che nelle Sacre Scritture non consta che Gesù abbia permesso che
apparisse sul suo viso divino questa "smorfia"; niente indica che Lui
abbia riso qualche volta).
La spiegazione, l'humor come conseguenza di un "umore"
esistente negli esseri umani, ha perso la sua credibilità sul piano in
cui la teoria degli "umori" non trovava spiegazione scientifica. Il
nome, tuttavia, è prevalso: l'umore.
Il critico russo Mikhail Bakhtin,
nella prima metà del 20° secolo, ha osservato che la storia dei giganti
Pantagruel e Gargantua, raccontata da Rabelais nel 16° secolo, non si lascia
ridurre a una parodia della narrazione medievale. Nessun racconto medievale presenta
qualcosa come l'utopica Abbazia di Theleme, il cui emblema, affisso al portone
d'ingresso, era "Fais ce que vouldras" (Fai quello che vuoi). Anche
il Don Chisciotte di Cervantes non si riduce a una parodia delle novelle
di cavalleria. Come classificheremmo il Tristram Shandy di Lawrence Sterne?
Possiamo verificare che in relazione a queste tre opere, giustamente, si è
parlato molto di umore.
Generalmente, l'umore non provoca risate. Si esprime,
prima, nel sorriso (parola che sarebbe stata creata da San Geronimo). Gradito
da sottigliezze e ambiguità. Vive di contraddizioni. E si mostra attento
alle contraddizioni intime della soggettività. L'umorista ritiene "buffe"
le persone che sono buffe senza sapere che lo sono. Pensa buffo il mondo. Ride
della condizione umana. E ride di se stesso (non si considera molto seriamente).
Manifestazioni
di humor ci sorprendono in opere "serie". Nell'Amleto di Shakespeare,
il principe uccide Polonio e, quando gli chiedono dov'è il consigliere,
risponde: "A cena". Aggiunge: "Non alla cena dove lui mangia, ma
a quella in cui è mangiato". Nello stesso Amleto, il principe
di Danimarca sente due becchini conversare, parlando di lui, senza che lo riconoscessero.
Dicono che Amleto è pazzo e per questo lo hanno mandato in Inghilterra.
E commentano: "Se lui fosse veramente pazzo, dovrebbe starci bene, perché
là tutti sono fuori di testa".
Questo è uno dei paradossi
dell'humor. Per elevarsi al livello filosofico dell'humor (ridere di se stesso),
il soggetto deve sviluppare una straordinaria capacità di distaccarsi dal
suo oggetto. Necessita di una notevole soddisfazione intellettuale e anche di
un po' di crudeltà.
Per fiorire, l'umore è solito andare oltre
il terreno marcato per la pratica della carità; è solito esonerarsi
dall'esercizio della solidarietà umana, nella sua espressione sentimentale.
Questo rimane molto chiaro quando l'inglese Jonathan Swift affronta il tema della
miseria dei bambini poveri in Irlanda. Invece di esprimere la sua solidarietà
in termini espliciti, appassionati, veementi e probabilmente innocui, Swift è
ricorso all'ironia e ha fatto un capolavoro dell'humor, riscotendo dai paesi dei
bambini poveri che avessero più iniziativa, che uccidessero i loro figli,
che li cucinassero e vendessero la loro carne, trasformata in delicati manicaretti,
disputati dai clienti dei migliori ristoranti.
La costruzione dell'humor è
complicata. André Gide ha detto una volta che con bei sentimenti si fa
mala letteratura. L'affermazione è discutibile. Più convincente
è la constatazione che con bei sentimenti è possibile fare barzellette
ma difficilmente si riuscirà a fare un humor di qualità, universalmente
accessibile (capace di oltrepassare le frontiere costituite dalle circostanze
particolari).
L'humor, nella letteratura, generalmente, tende a essere consumato
dal grande pubblico nelle sue forme più accessibili. E noi, in Brasile,
abbiamo avuto eccellenti umoristi, sempre sorprendenti, nel tratto o nelle parole,
generalmente abbastanza accessibili nelle loro invettive, nelle croniche e nei
racconti buffi, nei poemetti scherzosi, nelle satire e nelle frottole. Abbiamo
una squadra di fuoriclasse, da Emilio de Menezes a Carlito Maia e al Barone di
Itararé, passando per Millôr Fernandes, Henfil, Sérgio Porto
e Cassio Loredano, e tanti altri. (Evito di citare i compagni del supplemento
Quaderno B, per non sembrare scena di favoritismo, di adulatori. O, siccome
ora se ne parla tanto, e è contenuto nel Codice Penale, indizio di "formazione
di quadriglia").
Possiamo essere orgogliosi dell'humor nella nostra cultura.
E dobbiamo riconoscere che, attualmente, una delle fonti di questo humor è
la rivolta contro le classi dominanti (qualsiasi sia la loro sembianza); è
il pretesto contro gli approfittatori dell'onda del disprezzo che colpisce il nostro paese.
Il quadro davanti al quale ci siamo messi esigerebbe molto sarcasmo, molta contundenza,
molta presa in giro.
Molière, scrittore francese, autore di commedie
indimenticabili, già diceva che, per cucinare un animale di grande portata,
serve del sale grosso ("Il faut du gros sel pour saler les grosses bêtes").
I nostri umoristi stanno rispondendo esattamente a questa domanda. Stanno - con
piacere! - abbassando la stecca.
(Tratto dal supplemento Idéias del Jornal
do Brasil, dell'Ottobre 2005. Traduzione di Alessandro Giometti.)
 Leandro Konder, filosofo e sociologo brasiliano, insegna Teoria Politica all'Istituto
Bennett di Rio de Janeiro.
Leandro Konder, filosofo e sociologo brasiliano, insegna Teoria Politica all'Istituto
Bennett di Rio de Janeiro.
.

 Precedente Successivo
Precedente Successivo
  Copertina
Copertina
|
