 L’ORDA
L’ORDA

( – tre
brani del libro L’orda – quando gli albanesi
eravamo noi )
Gian
Antonio Stella
Di
tutta la storia della nostra emigrazione abbiamo tenuto solo
qualche pezzo. La straordinaria dimostrazione di forza, di
bravura e di resistenza dei nostri contadini in Brasile o
Argentina. Le curiosità di città come Nova Milano o Nova
Trento, sparse qua e là ma soprattutto negli Usa dove
si contano due Napoli, quattro Venezia e Palermo, cinque Roma.
Le lacrime per i minatori mandati in Belgio in cambio di 200
chili l’uno di carbone al giorno e morti in tragedie
come quella di Marcinelle. I successi di manager alla Lee Jacocca,
di politici alla Mario Cuomo, di un stuolo di attori da Rodolfo
Valentino a Robert de Niro, da Ann Bancroft (all’anagrafe
Anna Maria Italiano) a Leonardo Di Caprio. La generosità delle
rimesse dei veneti e dei friulani che hanno dato il via al
miracolo del Nordest. La stima conquistata alla Volkswagen
dai capireparto siciliani o calabresi. E su questi pezzi di
storia abbiamo costruito l’idea che noi eravamo diversi.
Di più: eravamo migliori.
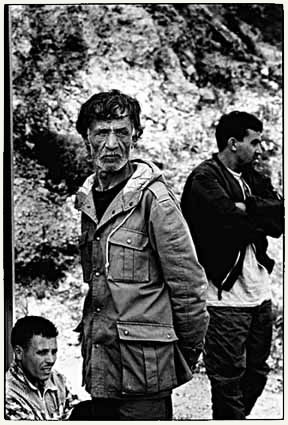 Non è così. Non c’è stereotipo rinfacciato
agli immigrati di oggi che non sia già stato rinfacciato,
un secolo o solo pochi anni fa, a noi. “Loro” sono
clandestini? Lo siamo stati anche noi: a milioni, tanto che i
consolati ci raccomandavano di pattugliare meglio i valichi alpini
e le coste non per gli arrivi ma per le partenze. “Loro” si
accalcano in osceni tuguri in condizioni igieniche rivoltanti?
L’abbiamo fatto anche noi, al punto che a New York il prete
irlandese Bernard Lynch teorizzava che “gli italiani riescono
a stare in uno spazio minore di qualsiasi altro popolo, se si
eccettuano, forse, i cinesi”. “Loro” vendono
le donne? Ce le siamo vendute anche noi, perfino ai bordelli
di Porto Said e del Maghreb. Sfruttano i bambini? Noi abbiamo
trafficato per decenni coi nostri, cedendoli agli sfruttatori
più infami o mettendoli all’asta nei mercati d’oltralpe.
Rubano il lavoro ai nostri disoccupati? Noi siamo stati massacrati,
con l’accusa di rubare il lavoro agli altri. Importano
criminalità? Noi ne abbiamo esportata dappertutto. Non è così. Non c’è stereotipo rinfacciato
agli immigrati di oggi che non sia già stato rinfacciato,
un secolo o solo pochi anni fa, a noi. “Loro” sono
clandestini? Lo siamo stati anche noi: a milioni, tanto che i
consolati ci raccomandavano di pattugliare meglio i valichi alpini
e le coste non per gli arrivi ma per le partenze. “Loro” si
accalcano in osceni tuguri in condizioni igieniche rivoltanti?
L’abbiamo fatto anche noi, al punto che a New York il prete
irlandese Bernard Lynch teorizzava che “gli italiani riescono
a stare in uno spazio minore di qualsiasi altro popolo, se si
eccettuano, forse, i cinesi”. “Loro” vendono
le donne? Ce le siamo vendute anche noi, perfino ai bordelli
di Porto Said e del Maghreb. Sfruttano i bambini? Noi abbiamo
trafficato per decenni coi nostri, cedendoli agli sfruttatori
più infami o mettendoli all’asta nei mercati d’oltralpe.
Rubano il lavoro ai nostri disoccupati? Noi siamo stati massacrati,
con l’accusa di rubare il lavoro agli altri. Importano
criminalità? Noi ne abbiamo esportata dappertutto.
Fanno troppi figli rispetto alla media italiana mettendo a
rischio i nostri equilibri demografici? Noi spaventavamo allo
stesso
modo gli altri. Basti leggere i reportage sugli Usa della giornalista
Amy Bernardy, i libri sull’Australia di Tito Cecilia
o Brasile per sempre di Francesca Massarotto. La quale
racconta che i nostri emigrati facevano in media 8,25 figli
a coppia ma
che nel Rio Grande do Sul “ne mettevano al mondo fino a
10, 12 e anche 15 così com’era nelle campagne del
Veneto, del Friuli e del Trentino”.
Perfino l’accusa più nuova dopo l’11 settembre,
cioè che tra gli immigrati ci sono “un sacco di
terroristi”, è per noi vecchissima: a seminare il
terrore nel mondo, per un paio di decenni, furono i nostri anarchici.
Come Mario Buda, un fanatico romagnolo che si faceva chiamare
Mike Boda e che il 16 settembre 1920 fece saltare per aria Wall
Street fermando il respiro di New York ottant’anni prima
di Osama Bin Laden. (...)
Una
xenofobia volta per volta coltivata, eccitata, cavalcata da
questo o quel movimento demagogico. E basata, da un secolo
all’altro, da un decennio all’altro, da un paese
all’altro, sugli stessi stereotipi. Le stesse paure.
Le stesse parole. Che riuscivano a far presa perfino su futuri
statisti come Winston Churchill il quale, in attesa di prendere
una cotta di cui poi si vergognerà per il Duce, sprezzantemente
chiamava gli italiani “suonatori d’organetto” e
l’Italia “la puttana d’Europa”. Opinione,
come vedremo, largamente condivisa nel mondo anglosassone.
Un esempio? Prendiamo l’Australia, che alla cerimonia di
apertura delle Olimpiadi di Sydney ha cercato di riscrivere la
storia in tinte pastello con la bambinuccia dai capelli rossi
che abbraccia il buon selvaggio aborigeno e idealmente tutti
gli immigrati. “Mi rincresce di dover dare l’allarme”,
ironizza nel luglio del 1925, sul Corriere, Filippo sacchi, ma “l’Italia
sta preparandosi a invadere l’Australia. Lo so, nessuno
da noi ne aveva mai avuto sentore. Eppure è un fatto ormai
denunziato e incontestabile. Vengono i brividi a pensare che
milioni di italiani si alzano tutte le mattine, si fanno la barba,
prendono in caffelatte ed escono per i loro affari, senza nemmeno
immaginare che il loro paese è sul punto nientemeno di
occupare un continente.”
Spiega, il grande inviato nel Queensland, che i giornali locali
sono pieni di titoli sull’ “invasione italiana” e
che al “congresso dell’Australian Native Association”,
così forte da avere 50.000 mila “aderenti d’ogni
ceto, specie industriale, commerciale e professionale”,
il presidente, mister Ginn, ha tuonato: “Che cosa è questo
improvviso intensificarsi del fiotto migratorio? C’è forse
qualche influenza in gioco? Qualche piano organizzato di penetrazione
pacifica? Australiani, all’erta. Badate che la vostra apatia
non prepari un terribile risveglio per i vostri figli. Noi non
vogliamo che le condizioni sociali ed economiche dell’Australia
siano minate da un inevitabile incrocio con gli stranieri, incapaci
di sentire le nostre tradizioni, di rispettare la nostra bandiera”.
Dopo di che l’assise si è chiusa “con un ordine
del giorno che invoca il diritto d’immigrazione in Australia
per le razze non affini e non confacentesi”. Cioè la
nostra.
Ma “perché tutto questo accanimento contro gli italiani?
Ve lo spiego io: per mantenere l’Australia ‘bianca’”,
ride amaro Sacchi. “Keep the Australia white, è la
vera parola d’ordine di questa crociata. Infatti noi non
siamo bianchi, siamo “oliva”. Olive-skinned influx,
diciamo.” E racconta che un grande quotidiano di Melbourne
ha titolato proprio così l’annuncio di un’inchiesta
del governo del Queensland sulla nostra immigrazione: “L’invasione
delle pelli-oliva”. E che al congresso delle donne “un’oratrice
autorevole, nell’esortare le massaie australiane a non
comperare frutta dai negozi italiani, anche se questi praticano
prezzi più moderati, lamenta che dopo aver tanto fatto
per difendere l’Australia ‘bianca’ della minaccia
degli asiatici, ‘emigranti oliva continuano a stabilirsi
nel paese’”. E si trattava in larghissima maggioranza,
sia detto per la memoria corta dei razzisti nostrani, di lombardi,
piemontesi, veneti...
“
Siamo tanto una razza degradata che si esortano le donne australiane
a non sposare i nostri emigranti”, prosegue l’inviato
del Corriere. E racconta che all’assemblea di Victoria
della “Rssila”, l’associazione dei combattenti, è stato
detto: “I matrimoni delle nostre donne con questi forestieri
fanno un’impressione disgustosa.” Bravi camerati!
Il nostro sangue sporca, imbratta, adultera il loro sangue australiano.
Pollute, polluted è l’espressione più concisa
e brutale di questo concetto. Ma anche quelli che parlano per
eufemismi si spiegano ugualmente chiaro”. E cita Sir John
McWhae, “rappresentante ufficiale a Londra di uno dei più importanti
stati dell’Australia”, contrario all’ipotesi
che i connazionali “diluiscano” il “puro sangue
britannico col sangue di stranieri che non [...] si confanno”.
Era per metà divertito e per metà fuori della grazia
di Dio, Filippo Sacchi, nello scrivere quello e altri articoli
del suo reportage durato alcuni mesi. E raccontò schifato
di un ricco uomo d’affari di Melbourne che aveva scritto: “Noi
abbiamo una vaga disistima di cotesti stranieri della pelle scura,
spesso di statura al disotto della normale, gesticolanti e irruenti”.
Di un giornale che tuonava: “Vogliamo popolare il nostro
territorio con nordici e con latini?”. E di un razzismo
così incolto che due o tre persone “vedendo un libro
o un giornale nostro, esprimono la loro gradevole sorpresa nel
costatare che abbiamo le stesse lettere dell’alfabeto e
gli stessi caratteri dei loro”.
Ce
l’avevamo cucita addosso, questa fama di “sozzoni”.
Né si può negare che spesso, per quanto tutto
vada inquadrato nel momento storico, ce l’andavamo a
cercare. Lo riconosceva la stessa stampa anarchica come Il
Risveglio, che nel novembre 1904 scriveva che i manovali di
una compagnia che lavoravano a qualche infrastruttura in mezzo
a un bosco “hanno costruito una baracca per non avere
da pagare l’alloggio e dormono per terra, in mezzo alle
immondizie, come maiali”. E se qualche razzista nostrano
vuol raccontare a se stesso che si trattava di “terroni”,
se lo tolga dalla testa: in quel momento, lì in Svizzera,
erano quasi tutti veneti: piemontesi, lombardi, liguri, emiliani...
Le descrizioni dei posti in cui dormivano i nostri, del resto,
sono incredibilmente simili da un capo all’altro del pianeta. “ Sablon,
presso Metz, visitai [...] alcune stanze a pian terreno che sembravano
stalle, e tali devono essere state un giorno, dove, secondo quanto
mi era stato detto, dovevano abitare circa cinquanta operai italiani.
Non aria, non luce; il letto consisteva anche qui in un vecchio
pagliericcio indecente. L’aria era umida, corrotta, fetente,
irrespirabile; solamente degli animali potevano vivere là dentro” racconta
Giacomo Pertile. “A Bochum, in Vestfalia, trovai [...]
circa cento operai di un paese degli Abruzzi che dormivano su
un po’ di paglia sparsa sulla nuda terra, come si usa per
gli animali; a Essen esistono ancora due baracche, dove gli operai,
tutti degli Abruzzi, dormono in casse di legno allineate per
terra, nelle quali ci sta un po’ di paglia con uno straccio
nero che serve da coperta, e un altro che serve da lenzuolo.
E quando alla mattina, nella semi-oscurità dei primi albori,
questi operai sollevano il capo dalle loro casse, essi destano,
in chi li vede per la prima volta, la macabra idea di una schiera
di morti che risorgono dalle loro bare”.
“È
con un senso profondo di umiliazione che mi accingo ad occuparmi
di questo argomento”, sospira De Michelis. “Ricordo
lo spettacolo a cui assistei, visitando di notte le camere degli
italiani nel villaggio di Naters, poco tempo dopo l’inizio
dei lavori del Sempione. Allora scrissi: “Sono stanzuccie
terrene, già adibite come ripostigli o stalle; basse di
soffitto, umide tutte, alcune con filtrazioni delle vicine latrine,
attorniate quasi sempre da quei fumiers (concimai) tanto spesso
indecenti nei piccoli villaggi del paese. In quelle stanze dormono
da otto a dieci, venti operai... due o tre per letto”.
Ma quello che allora [...] ignoravo, era che in quegli stessi
letti, a una mezz’ora di intervallo, dormivano in egual
numero e nello stesso modo altrettanti operai appartenenti alla
squadra di minatori a cui i primi dormienti avevano dovuto succedere
nella galleria!”.
In Belgio, dice ad Abramo Seghetto in Sopravvissuti per raccontare l’udinese Umberto Feletig, lui pure umiliato dai cartelli
di “affittasi” che intimavano “Etrangers,
s’abstenir” (Gli
stranieri si astengano), i minatori italiani nel secondo dopoguerra
vivevano “come nei pollai”. In dormitori chiamati “cantine” che
a volte erano immensi, spesso avevano due soli cessi per 1800
persone, come quello in cui finì Antonio Ciscato, quasi
sempre erano luridi. A Flenu ce n’erano due, di cantine.
E Giuseppe Sanson, un trevisano che arrivò lassù non
molto tempo fa da quella San Vendemiano oggi nota per Alex Del
Piero e la ricchezza pro capite, finì nella peggiore:
Eravamo in 120-130. La cantina era della società delle
miniere, e gestita da un solo cantiniere. [...] Il mangiare era
deplorevole, le stanze e la pulizia erano qualcosa di spaventoso.
[...] I gabinetti non funzionavano ed erano sempre sporchi. Le
lenzuola erano fatte lavare dal cantiniere ogni quindici giorni”.
L’europarlamentare leghista Mario Borghezio sale oggi sui
treni con le bombolette di disinfettante perché “le
nigeriane e i loro giganteschi gigolò spesso appoggiano
i loro piedi nudi e maleodoranti sui sedili, fanno operazioni
di toeletta personale anche podologica e divorano i cibi imbrattando
i convogli”. Ma dormirebbe uno dei nostri extracomunitari
di oggi nelle lenzuola cambiate ogni due settimane di un letto
usato insieme da due o tre minatori che diventano spesso quattro
o sei con la rotazione dei turni? Eppure così dormivano
i nostri nonni, fino a pochi decenni fa. Tanto che in Svizzera
un rapporto di polizia del quartiere di Spalen trovato da Manz
diceva che per risparmiare i nostri dormivano sempre nello stesso
letto in due, “alla maniera italiana”. E in Inghilterra
la rivista medica Lancet pubblicava un dossier secondo il quale,
come ricorda Lucio Sponza, “il sovraffollamento e la sporcizia
tra gli italiani erano presentati come il loro stile di vita
naturale”. Diceva infatti: “Gli italiani sono alloggiati
miseramente, stretti assieme quattro o cinque per letto, quando
ne hanno uno in cui dormire. [...] Per loro la parola ‘casa’,
così sacra alle orecchie degli inglesi, non ha nessun
significato e per loro la decenza, la pulizia e la modestia sono
cose inimmaginabili”. Insomma: “Aderiscono al loro
innato amore per il sovraffollamento, l’aria viziata e
la sporcizia”.
(Brani
tratti dal libro L’orda – quando gli albanesi eravamo
noi, Rizzoli, Milano, 2002)
 Gian
Antonio Stella Gian
Antonio Stella
 Successivo
Successivo
 SPAZIO
SAGARANA SPAZIO
SAGARANA  Copertina
Copertina
|